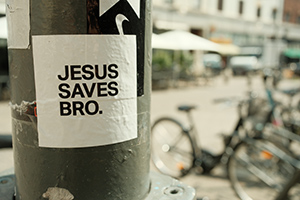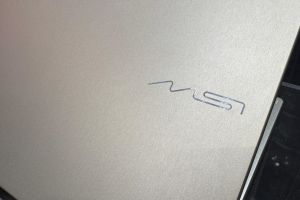8 mesi con Garmin Forerunner 920XT

Un test di lunga durata per Forerunner 920XT, lo sportwatch di Garmin sviluppato per venire incontro alle esigenze specifiche degli appassionati di triathlon ma adatto in generale ai podisti appassionati di lunghe distanze
di Paolo Corsini pubblicato il 21 Settembre 2015 nel canale WearablesGarmin
Running Dynamics e VO2 Max
Con Forerunner 620 Garmin ha introdotto per la prima volta quelle che sono indicate come Running Dynamics. Abbinando questo sportwatch alla fascia cardio HRM-Run, che integra al proprio interno un oscilloscopio, è possibile avere una serie di dati integrativi rispetto a quelli tradizionalmente forniti da uno sportwatch. In dettaglio queste sono le metriche di corsa fornite da Garmin con Forerunner 920XT, le stesse implementate anche nei modelli Fenix 2, Fenix 3 e Epix.
- cadenza: è il numero di passi che un'atleta esegue durante l'azione di corsa in un minuto. In genere questa metrica viene riportata con riferimento ad un solo piede (esempio: cadenza 90 passi al minuto con riferimento al piede sinistro) mentre nella reportistica fornita da Garmin viene indicata la cadenza combinata di entrambi i piedi (nell'esempio appena citato otteniamo una cadenza complessiva di 180 passi al minuto). Maggiore è la cadenza, a parità di altre caratteristiche, superiore sarà la velocità. La cadenza è un dato che varia molto da atleta ad atleta; quale regola generale segnaliamo che atleti più alti tendono ad avere una cadenza più ridotta rispetto ad atleti più bassi. In generale la stragrande maggioranza degli atleti ha una cadenza compresa tra 150 e 200 passi al minuti, a prescindere dalla loro velocità di corsa, con un compromesso ideale dato da circa 180 passi al minuto. Il dato di cadenza è fornito anche da altri prodotti Garmin destinati ai podisti, non abbinati però alle Running Dynamics: parliamo ad esempio dei modelli Forerunner 220 e Forerunner 225, che integrano al proprio interno un accelerometro specifico per questa funzionalità.
- tempo di contatto: è il tempo durante il quale il piede mantiene contatto con il terreno, espresso in millisecondi. Minore questo dato più veloce sarà la nostra azione di corsa, in quanto un tempo di contatto ridotto permette di ottenere una risposta di corsa più rapida. La maggior parte degli atleti ha un tempo di contatto medio compreso tra 190 e 330 millisecondi; gli atleti elite hanno tipicamente un tempo di contatto a terra inferiore a 200 millisecondi.
- oscillazione verticale: indica lo spostamento verso l'alto del corpo del corridore durante l'azione di corsa. Più contenuta è l'oscillazione verticale più efficiente sarà l'azione di corsa, e quindi tipicamente più veloce, in quanto saranno minimizzati gli spostamenti verticali che non permettono di avanzare ma che sono indispensabili per poter procedere con l'azione di corsa. L'oscillazione verticale media è compresa tra 6 e 13 cm e anche in questo caso è influenzata dall'altezza dell'atleta.
I dati delle metriche di corsa sono riportati all'interno della nostra sessione di allenamento visualizzabile via Garmin Connect, il tool online dell'azienda americana che permette di registrare lo storico delle nostre attività sportive. Al momento attuale questi dati non possono venir gestiti da altri programmi o applicazioni quali Strava, Runtastic, Runkeeper o Training Peaks ma rimangono di esclusiva competenza dei tool Garmin.
| Il grafico riporta i dati di sintesi di una sessione di allenamento di corsa,
un'uscita di 30 km che comprende 5km di riscaldamento in piano, una salita di 6km seguita
da 6,5km in discesa e dalla distanza rimanente in piano corsa in lieve progressione. Dall'alto verso il basso abbiamo indicazione dell'altimetria del percorso, del passo medio, della frequenza cardiaca e delle 3 dinamiche di corsa: cadenza, oscillazione verticale e tempo di contatto con il suolo. In funzione del tipo di percorso cambiano queste metriche: l'oscillazione verticale è più contenuta lungo la corsa in salita, mentre il tempo di contatto al suolo si alza |
I grafici riportano le varie metriche con colorazioni differenti, volendo in questo meglio definire quale sia l'intensità complessiva dell'attività secondo le dinamiche di corsa.

I riferimenti medi sono stati ottenuti da Garmin analizzando il comportamento di diversi corridori, caratterizzati da azione di corsa e prestazioni molto differenti tra di loro. Possiamo sintetizzare affermando che se la nostra colorazione di riferimento sarà di un certo tipo è molto probabile che anche l'indicazione del nostro VO2 max, della quale parliamo in seguito, ricada in quell'intervallo medio.
Le Running Dynamics forniscono informazioni interessanti per il podista appassionato, e che in un certo senso possono fornire informazioni dettagliate su eventuali limiti della propria azione di corsa. Pensiamo ad esempio alla cadenza, che se troppo ridotta può implicare un'azione di corsa dalla falcata troppo ampia e dispendiosa rispetto ad una corsa efficiente, con un tempo di appoggio che tende ad allungarsi. Dopo i primi giorni di utilizzo, durante i quali si passa del tempo a verificare quale sia stata l'azione di corsa durante la seduta di allenamento secondo le metriche del Running Dynamics, ho onestamente perso interesse verso questi dati complice anche il fatto di potervi accedere solo tramite Garmin Connect e non anche con l'importing dell'attività in altri sistemi. Detto in altro modo, dopo un iniziale entusiasmo le Running Dynamics hanno perso l'iniziale appeal diventando un dato che registro ma che di fatto non consulto mai salvo casi sporadici in presenza di allenamenti molto particolari.
Ben più interessante, per la mia esperienza d'uso, è l'indicazione della stima (perché di questo si tratta) del VO2 Max: questo è un dato molto importante per gli atleti appassionati di sport di lunga distanza, in quanto indica il massimo consumo di ossigeno in millilitri per kg di peso corporeo al minuto. Più elevato è questo valore, migliore è l'efficienza dell'atleta e la sua capacità di sostenere sforzi particolarmente intensi per un periodo di tempo lungo. Per poter ottenere questa indicazione è tipicamente necessario recarsi in un centro di medicina sportiva ed eseguire un test specifico, collegati ad un'apparecchiatura che misura il proprio consumo di ossigeno e da questo ricavare il proprio VO2 Max.

A partire dal modello Forerunner 620 Garmin ha implementato un sistema di stima del VO2 Max nei propri sportwatch di fascia più alta, abbinando i dati dell'attività come tempo e distanza a quelli forniti dal battito cardiaco rilevato dalla fascia a petto. Per ottenere una prima stima del proprio VO2 Max è necessario completare una sessione di allenamento di almeno 10 minuti di durata; una volta completata la prima elaborazione il proprio VO2 Max verrà calcolato e lo storico dei dati reso disponile nel proprio profilo Garmin Connect. In Forerunner 920XT, trattandosi di un prodotto rivolto agli appassionati di triathlon, è stata implementata anche una modalità di stima del VO2 Max specifica per il ciclismo accanto a quella di corsa.

VO2 Max stimato per la corsa
L'indicazione del VO2 Max permette di avere un parametro di riferimento di quella che è la propria condizione atletica del momento. Completato il primo allenamento 920XT fornisce una prima indicazione, che tipicamente sottostima di molto quella che è la condizione effettiva dell'atleta; sarà solo con vari allenamenti seguenti che il VO2 Max salirà sino a stabilizzarsi verso una indicazione che stimi abbastanza correttamente quello che è il proprio effettivo livello.
Partendo dal VO2 Max Forerunner 920XT stima quelli che sono i tempi di corsa di alcune delle principali distanze in una gara di corsa (5k, 10k, mezza maratona e maratona) fornendo una indicazione di riferimento circa quelli che potrebbero essere i propri massimali. Il dato è solo un riferimento di massima che può aiutare a capire dove ci si può spingere ma non di certo una sorta di risultato garantito sul tempo con il quale chiuderemo una di queste distanze. La mia esperienza personale, comune a quella di amici che utilizzano sportwatch Garmin dotati di questa funzionalità, è che soprattutto per le distanze di mezza maratona e di maratona le indicazioni della previsione gara tendano ad essere un po' troppo ottimistiche.
Affinché la stima del VO2 Max, e di conseguenza di quelli che sono i tempi stimati sulle distanze, sia corretta è fondamentale indicare con correttezza quella che è la propria frequenza cardiaca massima. Per ottenerla si può partire dalla tradizionale formula (220-età), ma questa è una base di partenza che non rispecchia quella che è la propria FC massima sotto sforzo. La FC massima è un dato di picco, che difficilmente viene ottenuto a meno di non ricercare uno sforzo massimale: un modo può essere quello di partecipare ad una gara di breve distanza, 5km o 10km, con una volata "all'ultimo respiro" per guadagnare una posizione. In uno scenario di questo tipo, se ci si impegna al 100% delle proprie capacità, è molto probabile che il dato di frequenza cardiaca massima ottenuto sia quello della FC massima in assoluto, o al massimo inferiore di 1 o 2 battiti. Tutto questo presuppone in ogni caso di arrivare a questo test non in sovrallenamento, viceversa è molto probabile che anche con un impegno massimale la frequenza cardiaca non tocchi il picco massimo.
Dicevamo dell'importanza di indicare correttamente la propria FC massima per ottenere una stima corretta del VO2 Max e delle grandezze a questo associato. Se la FC massima è correttamente indicata l'intensità della nostra sessione di allenamento, o della nostra gara, sarà riparametrata sulla FC massima fornendo quindi una stima corretta. Se indichiamo una FC massima pari a 190 battiti al minuto, quando in realtà la nostra FC massima non supera i 175 battiti al minuto, otterremo una stima del VO2 Max assolutamente sbilanciata verso l'alto: una corsa con FC media di 165 battiti verrà letta da Forerunner 920XT come di media intensità in quanto riparametrata sui 190 battiti indicati come massimi, mentre alla luce della FC massima effettiva di 175 battiti si tratterà di una sessione a ben più elevata intensità.
E' importante quindi misurare la propria FC massima, eseguendo il semplice test di prima o in alternativa una serie di ripetute in salita spinte al massimo dello sforzo (leggi: non riesco a fare un metro di più e mi butto a terra dalla fatica), così da capire quale essa sia e non basarsi se non inizialmente sulla regola (220-età). Ho alcuni esempi pratici di atleti amici che rappresentano come la regola 220-età non sia da prendere come valida sempre:
- podista di 43 anni: secondo la regola la sua FC massima è di 177 battiti al minuto, ma in una gara di ridotta distanza ha raggiunto un picco di 202 battiti al minuto, andando abitualmente oltre soglia 190 per un impegno massimale. Questo è un esempio di un cuore che si spinge su valori ben superiori a quelli che per età ci si attende;
- podista di 38 anni: secondo la regola la sua FC massima sarebbe di 182 battiti al minuto. In una gara di 10km dove ha ottenuto il personale ha toccato una FC massima di 161 battiti al minuto. Questo è l'esempio di un podista che per conformazione ha battiti massimi inferiori a quello che la regola (220-età) porterebbe a pensare;
- chi scrive in queste pagine: a 41 anni di età dovrei avere una FC massima di 179 battiti al minuto. In volate di gare brevi ho toccato 184 battiti al minuto, con quindi uno scostamento significativo per quanto non elevatissimo rispetto a quanto indicato dalla regola (220-età).
Tutti siamo diversi dagli altri dal punto di vista cardiaco: ecco perché è importante monitorare il proprio battito durante l'azione di corsa e da questo ricavare quella che è la frequenza cardiaca di picco di cui si è capaci.

stima del VO2 Max per il ciclismo
La stima del VO2 Max per le attività di ciclismo richiede l'abbinamento ad un sensore di potenza, montato sulla propria bicicletta e interfacciato con lo sportwatch. Questo rende difficilmente accessibile alla maggior parte degli utenti tale metrica, in quanto i sensori di potenza rimangono un accessorio ancora molto costoso non utilizzato dalla maggior parte dei cicloamatori.








 BOOX Note Air4 C è uno spettacolo: il tablet E Ink con Android per lettura e scrittura
BOOX Note Air4 C è uno spettacolo: il tablet E Ink con Android per lettura e scrittura Recensione Sony Xperia 1 VII: lo smartphone per gli appassionati di fotografia
Recensione Sony Xperia 1 VII: lo smartphone per gli appassionati di fotografia Attenti a Poco F7: può essere il best buy del 2025. Recensione
Attenti a Poco F7: può essere il best buy del 2025. Recensione DJI OSMO Mobile SE a 69€: il gimbal compatto che trasforma i video dello smartphone in riprese da pro
DJI OSMO Mobile SE a 69€: il gimbal compatto che trasforma i video dello smartphone in riprese da pro Scope elettriche da record su Amazon: due modelli potentissimi sotto i 120€, ecco perché piacciono così tanto
Scope elettriche da record su Amazon: due modelli potentissimi sotto i 120€, ecco perché piacciono così tanto GTA 6 a 80 euro? Take-Two frena sul prezzo e punta tutto sul valore percepito
GTA 6 a 80 euro? Take-Two frena sul prezzo e punta tutto sul valore percepito I 3 portatili più convenienti su Amazon: sono 2 tuttofare Lenovo e un HP Victus gaming con RTX 5060
I 3 portatili più convenienti su Amazon: sono 2 tuttofare Lenovo e un HP Victus gaming con RTX 5060 AirPods Pro 2 a soli 199€: su Amazon anche AirPods 4 in sconto, ecco le differenze che contano
AirPods Pro 2 a soli 199€: su Amazon anche AirPods 4 in sconto, ecco le differenze che contano 2 Smart TV 4K Hisense con doppio sconto su Amazon: sono OLED e QLED, 55" e 75", fateci un bel pensierino
2 Smart TV 4K Hisense con doppio sconto su Amazon: sono OLED e QLED, 55" e 75", fateci un bel pensierino Portatili Apple ai minimi: MacBook Pro con chip M4 a 1.648€ e Macbook Air 13 16GB7256GB, sempre M4, a 998€
Portatili Apple ai minimi: MacBook Pro con chip M4 a 1.648€ e Macbook Air 13 16GB7256GB, sempre M4, a 998€ Come mantenere Windows 10 sicuro dopo il 2025: tutto sul programma ESU
Come mantenere Windows 10 sicuro dopo il 2025: tutto sul programma ESU Finalmente è tornato su Amazon l'iPhone 16 128GB a 749€, in tutti i colori, ma ci sono anche i 16e e 16 Pro in offerta
Finalmente è tornato su Amazon l'iPhone 16 128GB a 749€, in tutti i colori, ma ci sono anche i 16e e 16 Pro in offerta Auto nuove? Per il 65% degli italiani sono troppo care, non dovrebbero costare oltre i 20.000 euro
Auto nuove? Per il 65% degli italiani sono troppo care, non dovrebbero costare oltre i 20.000 euro Droni solari Airbus volano nella stratosfera grazie alle nuove batterie al silicio: test riusciti a oltre 20 km di quota
Droni solari Airbus volano nella stratosfera grazie alle nuove batterie al silicio: test riusciti a oltre 20 km di quota Colpo da 15 milioni di dollari: chi ha rubato un carico di prodotti AMD e Apple?
Colpo da 15 milioni di dollari: chi ha rubato un carico di prodotti AMD e Apple? Elon Musk lancia l'allarme su GPT-5: 'OpenAI divorerà Microsoft'. Ma Nadella lo sfida con un sorriso
Elon Musk lancia l'allarme su GPT-5: 'OpenAI divorerà Microsoft'. Ma Nadella lo sfida con un sorriso iPhone 17 Pro sarà più costoso, ma anche più conveniente
iPhone 17 Pro sarà più costoso, ma anche più conveniente